
Naxos
Questo post nasce da un paio di fatti che mi sono capitati negli ultimi giorni. Il primo è stato un video, commovente, regalatomi dalle amiche con foto improbabili uscite da vecchi album: fra le altre, sono spuntate immagini cartacee di Corfù, di tende e traghetti presi nella notte. E poi due chiacchiere con don Domenico, parroco della chiesa dietro casa. Raccontando del suo annuale viaggio in Grecia, ha detto che ognuno di noi ha il suo paese d’elezione, una seconda patria. E, manco a dirlo, la sua è proprio questa terra di miti ed eroi. Ormai avevamo preso una brutta piega, mettendoci a rievocare in ordine sparso versioni di greco, Saffo e lacrime a Micene (capita ai malcapitati studenti del liceo classico). Anche per me questo Paese è speciale, con il suo relax accogliente, il suo azzurro, la magia sprigionata delle poche rovine rimaste. L’ho snobbata per anni pensando che tanto era dietro l’angolo e avrei avuto tanto tempo per andarci, un giorno. E invece i propri ‘luoghi’ bisogna inseguirli sempre, il prima possibile, per riequilibrare le nostre vite passate a rincorrere il tempo. “La Grecia? Quattro sassi”, diceva quando ero piccola un collega di mio padre.
Per me non è così e soprattutto le isole sono posti in cui vorrei tornare tutti gli anni. Anche perché serve tempo per vederle tutte: tanti frammenti in quel mare stupendo che è l’Egeo. Nel caso in cui qualcuno sia indeciso su quali vistare, ecco qui le mie. Non sono tante, ma tutte con una personalità molto diversa. Metto le mani avanti: alcune le ho viste una decina di anni fa, ma credo che lo spirito dei luoghi ci metta un po’ a cambiare (fortunatamente è un po’ cambiata la qualità delle foto, invece).
Paxos, fuga

Paxos, qualche anno fa
Parto da questa isola delle Ionie perché è stata la prima che ho visto. Sono arrivata in traghetto dall’Italia: cinque amiche e un appartamento per due giorni. L’isola è davvero minuscola (non c’era neppure l’acqua, la portavano, ricordo, dalla terraferma) e ancora più piccola è l’isoletta che le sta davanti (anti-Paxos), che si raggiunge con un breve tragitto in barca. Un giorno abbiamo noleggiato l’auto e praticamente l’abbiamo girata tutta in poche ore. Mi è piaciuto il senso di isolamento, la tranquillità di Gaios, il villaggio di pescatori principale, il bel mare azzurro. Scendendo lungo un sentiero fra gli ulivi abbiamo scovato una incantevole caletta: questo è il modo di vivere il mare qui. Ecco quindi un piccolo rifugio per sentirsi fuori dal mondo: alla Grecia riesce alla perfezione questo ruolo di porto che mette al riparo dai pensieri pesanti e rumorosi.
Come arrivare: dal porto di Igoumenitsa (avevamo viaggiato tutta la notte prima da Ancona) si prende un traghetto. Il viaggio dura circa un’ora e mezzo.
Corfù, amicizia

Pineta e mare a Corfù
Sono passati dieci anni, ma il ricordo più netto è l’assalto dei proprietari di case appena messo piede giù dal traghetto. Il secondo è che Corfù, rispetto a Paxos, sembrava enorme. E in effetti questa isola è molto grande e me la ricordo divisa a metà: il sud era praticamente in ostaggio di inglesi in vacanza, fra pub, musica a tutto volume e ragazzini ubriachi e guardie mediche. Per una sera ci divertimmo molto, ma direi che alla lunga è meglio girare alla larga. Corfù non è la classica isola greca idilliaca con casette bianche, ma offre la possibilità di fare parecchi giri (consiglio il noleggio dell’auto viste le dimensioni) e provare tantissime spiagge diverse. La città di Corfù ha una marcata impronta veneziana, me la ricordo vivace, piena di vicoli e negozietti. Noi abbiamo fatto base al campeggio Dionysus, carino e pulito e piuttosto vicino alla città principale. Un buon punto in cui fare amicizie, begli incontri e tante chiacchiere fra amiche. Qualche posto che consiglierei: la spiaggia di ciottoli, dall’acqua freddissima, di Paleokastritsa; il paesino di Kassiopi, per mangiare sul mare, la spiaggia argillosa di Sidari con il canale dell’amore. E poi una gita al monte Pantokrator, per visitare monasteri e fermarsi nelle taverne a mangiare il pesantissimo sofrito. E poi una tappa d’obbligo alla villa dei Durrel: se non avete ancora letto il romanzo ‘La mia famiglia e altri animali’, beh, dovete recuperare subito.
E’ un’isola verde, vasta. Meno affascinante di altre, ma ha il grande vantaggio di essere divertente, con una buona vita notturna e, per chi preferisce spostarsi in traghetto, molto vicina all’Italia.
Come arrivare: sempre dal porto di Igoumenitsa. In alternativa si può anche prendere l’aereo (vola pure la Ryan Air).
Naxos, ritorno

La ‘Portara’ (Foto di Patrick Colgan, 2013)
Il mio ritorno in Grecia inizia con la scoperta delle Cicladi, l’arcipelago più vicino all’idea che più comunemente abbiamo delle isole: paesaggio estivo brullo, case bianche colorate delle bouganville e mare di un blu intenso. Naxos la scegliemmo perché aveva tanti ingredienti: dimensioni medie, per potere girare bene tutta l’isola in cinque/sei giorni, una buona cucina, alcune valli verdi adatte alla coltivazione della vite, villaggi immacolati dove resistono le tradizioni legate alla musica dionisiaca. E, appunto, una buona dose di mitologia legata a Teseo e Arianna (quelli del minotauro per intendersi); alcuni resti archeologici rafforzano questo aspetto, prima su tutti la ‘Portara’. Questa apertura sul mare, l’unica cosa che resta del tempio di Apollo, è l’immagine più suggestiva, soprattutto al tramonto, quando la gente si raduna sulla scogliera per vedere il disco solare tuffarsi in mare dietro il marmo. E poi ci sono i kuroi, due giovani di pietra addormentati da secoli nella boscaglia. Insomma, Naxos è un’isola che ben conosce il turismo – come dimostra l’affollato passeggio sul lungo mare di Chora la sera-, ma che lo sa gestire. Più adatto forse alle famiglie o alle coppie più che ai giovani in cerca di divertimento (per quello si può scendere alla fermata prima, Paros), offre comunque alcuni locali molto carini. Il nostro preferito era il Kitron, dove propongono il liquore tradizionale anche in versione cocktail.

Koronida, Naxos (Persorsi, 2013)

Naxos (Foto di Patrick Colgan)
Qualche suggerimento: sono suggestivi i due paesini dell’interno Koronos e Koronida: macchie bianche in un susseguirsi di stradine e vicoli. Vale il viaggio una pausa da Matina Stavros per una moussaka da gustare sotto il pergolato. E poi le miniere, abbandonate, di smeriglio: i vecchi binari regalano scene da far west. E poi le chiese: ce n’è una per ogni giorno dell’anno: sorgono ovunque, su ogni altura o vallata come puntini da unire di un grande disegno.
Come ci si arriva: dal Pireo di Atene. Il traghetto lento impiega circa 6 ore, ma il viaggio si accorcia molto (ma costa circa il doppio) sulla nave veloce. Lo consiglio comunque a chi non ha l’auto. Resta anche l’opzione aereo.
Santorini, mistero
E’ impossibile non lasciarsi avvolgere da questa sensazione, nonostante la ressa di turisti a Firà cerchi in tutto modi di intaccare il fascino di questa isola bruna, bruscamente mutilata dall’eruzione vulcanica di 3.600 anni fa. Anche se per vedere un tramonto a Oia bisogna sgomitare fra gente di ogni nazionalità (io ci sono stata a inizio luglio, sicuramente un periodo molto gettonato) e la vita è molto più cara che in altre isole, Santorini resta uno di quei luoghi del nostro Mediterraneo dedicati ai sognatori. A chi, camminando sull’isoletta sorta nel cuore della caldera, chiudendo gli occhi viaggia nel tempo fino a una civiltà lontana, spazzata via, in fondo al mare, da quella violenta esplosione. I fiori gialli che spuntano fra le rocce laviche e la terra che fuma mi hanno fatto pensare alla vita che continua dopo i cambiamenti, dopo i terremoti che tutti ogni tanto attraversiamo. Ci possono portare via un pezzo di noi, forse, ma la bellezza attorno resta. Basta già questa visita (tutti i giorni nel porto vecchio partono le barche per le escursioni), e una colazione fatta la mattina presto su un mare intenso e commovente per prendere il traghetto (o l’aereo) e venirsene qui. Ma, per fortuna, non c’è solo questo.

Taverne sulla spiaggia, Santorini (Persorsi, 2014)

Asinelli per turisti

Firà sulla caldera

Santorini dalla caldera
C’è un’interessante strada del vino, per soste e degustazioni (ne ho scritto qui). C’è un paesino placido, Pyrgos, da cui si osserva il trambusto da lontano, che ospita un ristorante straordinario, Selene. E poi ci sono le tre spiagge che si raggiungono in barca (scendendo proprio in acqua fino alla riva): la Black, la White (la mia preferita) e la Red beach. Noi le abbiamo girate tutte in un pomeriggio, si paga cinque euro per un passaggio unico.
Come si arriva: dal Pireo sono circa cinque ore con la nave veloce. Ci sono comunque moltissimi voli charter.
Altri link: Bevuta con vista a Santorini
Amorgos, amore
E’ una delle poche isole in cui sono arrivata di giorno, vedendo il porticciolo di Katapola, ingrandirsi pian piano. Con Amorgos è stato amore a prima vista. L’ho capito subito, mentre in auto ci arrampicavamo in modo insolito, passando per cime brulle, popolate da capre, con mulini a vento in lontananza. Per non parlare del primo pranzo a Aegiali, la nostra base, sotto un pergolato. Le melanzane ripiene e la retsina avevano un sapore genuino, rustico. Abbiamo mangiato a fianco a una chiesetta, guardando pesci e farfalle dipinti in terra, per poi comprare un ombrellone e dormicchiare in spiaggia. Amorgos è così: ci si sente in un luogo un po’ selvaggio, agreste, ma con una insolita grazia dettata, credo, dal fatto di non avere perso la propria anima. Non a caso qui l’aereo non arriva, limitando le frotte di turisti e l’isola, lunga e stretta, è attraversata da delle cime che rendono gli spostamenti abbastanza lunghi. Non esiste la fretta, non ci sono pullman, ma solo spiagge, un relitto e un monastero bianchissimo aggrappato alla scogliera.

Il monastero della Panagia Hoziovotissa

Amorgos (foto Persorsi, 2014)

Katapola, ad Amorgos

Amorgos, isola di Nikouria (Persorsi, 2014)
Capitolo spiagge: secondo me la più bella è quella di Agios Pavlos, ma mi è piaciuta molto anche quella, al sud, di Kalokaritissa. Qui vicino, per altro, si può vedere il celebre relitto che ha ispirato il film di Luc Besson Le grand bleu. Per quanto riguarda i paesi, incantevole è il centro di Chora, il capoluogo nell’interno: si susseguono chiese, terrazze, pergolati e ristorantini perfetti per un aperitivo. Consiglio vivamente, però, di soggiornare a Aegiali, con graziosi localini animati la sera e il centro diving, o in uno dei paesini che sovrastano il secondo porto dell’isola (è una delle poche ad averne mantenuti due): Potamos, Langada e Tholaria. Sembrano usciti da un’altra epoca con le loro stradine, le scale bordate di bianco e pittoresche taverne. Non posso non nominarne una: Koreutes. Un po’ perché ci sono stata l’ultima sera, già carica di nostalgia. Un po’ perché, davanti alle lucine colorate che tremolavano sul mare, non capita tutti i giorni di ricevere una proposta di matrimonio.
Come si arriva: come dicevo i porti sono due, Katapola e Aegiali. In questo caso il collegamento con Atene è doppio: le navi arrivano sia al Pireo che a Egina. Da qui un autobus arriva direttamente in aeroporto.
Altri link: Andamento lento, Amorgos

































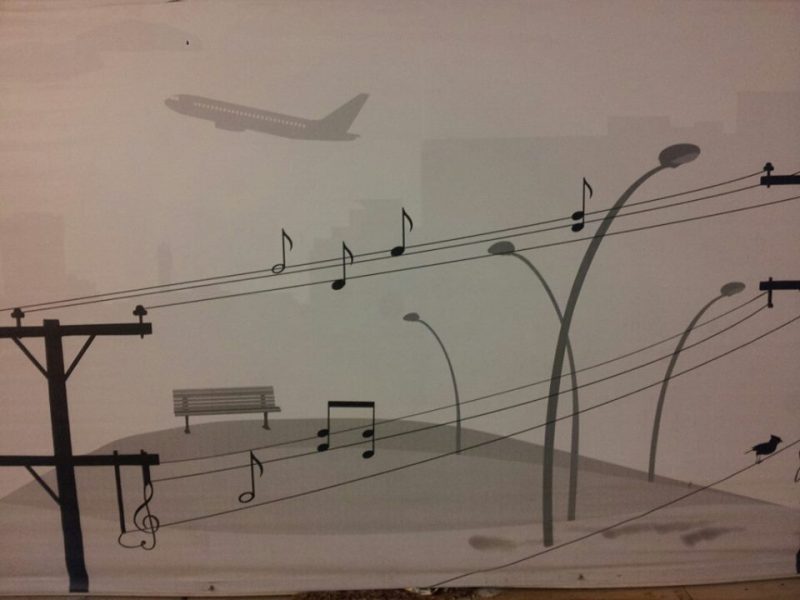



































 Curry rosso di granchio al Mango tree
Curry rosso di granchio al Mango tree



























