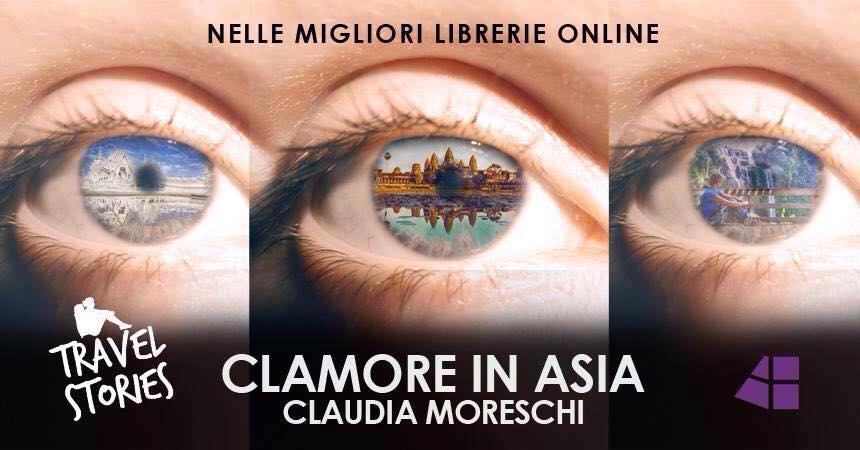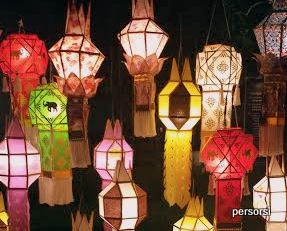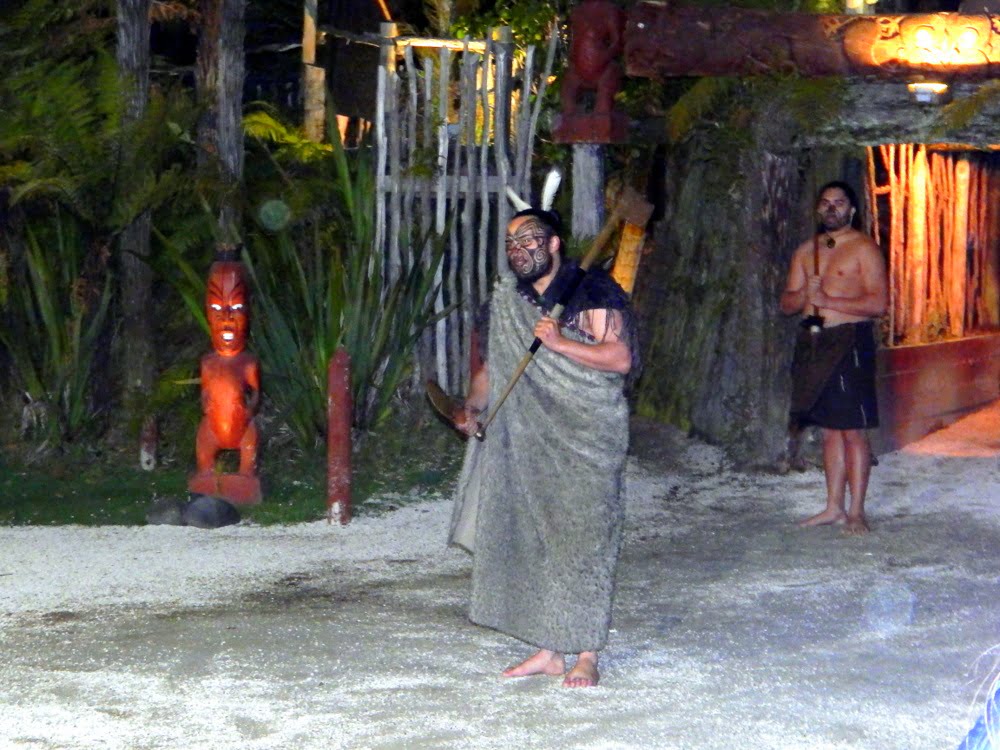Venezia è una città che non mi stanca mai e in cui cerco di tornare almeno una volta l’anno. L’ho vista in tanti momenti diversi: nel caldo del Festival del Cinema, tornando di notte dal Lido davanti a una distesa di luci galleggianti sull’acqua. L’ho visitata nelle giornate terse invernali, quando il cielo azzurro si srotola come una tela dietro palazzi senza tempo. L’ho vista fra i colori del Carnevale e sulle passerelle per l’acqua alta in una bolla d’umidità. L’ultima volta è stata poche settimane fa, a inizio primavera, e sono andata alla ricerca di angoli che ancora non avevo scoperto o che meritavano decisamente un secondo passaggio. Il momento che amo di più, però, resta l’arrivo col treno, quando ci si lascia alle spalle Mestre e all’improvviso si spalanca la Laguna. Venezia è lì che ti aspetta, dopo quel braccio di ferrovia. E sembra aspettarti da secoli.
1) Lo squero di San Trovaso
Di solito Venezia mi suggerisce atmosfere orientali, come se fosse una porta verso Est, anche per come ho ritrovato le tracce della Serenissima viaggiando nei Balcani o in Grecia. E invece questa ‘officina delle gondole’, lo squero di San Trovaso (uno dei pochi ancora in attività) mi ha fatto pensare al Nord, alle Dolomiti. In effetti gli operai che lavoravano qui venivano dal bellunese, per questo si trovano ancora abitazioni di legno tipiche della montagna. Dietro il ricovero per le barche si può visitare anche una chiesa particolare: è San Trovaso. Se vedete due ingressi uguali non avete bevuto troppo spritz: erano gli accessi separati in chiesa di due clan rivali. Dall’altra parte del canale, poi, c’è un simpatico bacaro, l’Osteria al squero: ottimo il crostino con baccalà mantecato.
2) San Barnaba
Non so se avete la fissa come me della saga di Indiana Jones, ma nel caso questa chiesa avrà un aspetto familiare. Avete presente la scena dell’Ultima Crociata in cui il fascinoso archeologo entra in una biblioteca (dove la x che è sempre il punto dove scavare)? Ecco, il campo in cui è girata quella sequenza in cui si vedono bene una chiesa bianca con facciata settecentesca e la piazzetta con i tavolini è proprio questo. Ps. le catacombe però a Venezia mica esistono, non cercatele!
3) Basilica dei Frari
E’ un vero scrigno di tesori e il monumento funebre di Antonio Canova merita l’ingresso in questo complesso francescano (chiude alle 17.30, si può anche fare un biglietto comulativo per le chiese da 12 euro). Lo trovate subito sulla sinistra appena entrati: il bianco della grande piramide di marmo contrasta con la porta nera socchiusa al centro. E’ l’accesso a un altro mondo, impossibile per noi -proprio come per l’uomo in generale – vedere al di là di quella porta. Molto belle anche le cappelle dell’abside: è decisamente un suggestivo bagno di arte sacra.
4) San Giorgio
Un’altra tappa in chiesa, ma questa volta per salire sul campanile di San Giorgio. Siamo nella piccola isola, proprio a fianco alla Giudecca, raggiungibile col vaporetto numero 2 da San Zaccaria (molo B). Rispetto a piazza San Marco, la coda è nettamente inferiore (se non assente) e da questo campanile la vista sui sestieri di Venezia è molto suggestiva. Si riconoscono bene la forma caratteristica della città e la disposizione delle tante piccole isole che compongono quella costellazione acquatica che è la Laguna. Occhio a quando suona la campana!
5) Il mercato di Rialto
Mercato di #rialto #rialtobridge #venezia #venice #veneziadavivere
Una foto pubblicata da letizia (@letidzia) in data:
Di solito amo dormire a Cannaregio, per essere vicina alla zona del Ghetto ebraico (la mia preferita), ma l’ultima volta abbiamo trovato una buona offerta proprio a un passo dal ponte di Rialto (a proposito, ho scoperto che marzo è uno dei momenti migliori per quanto riguarda i prezzi e in generale il periodo fra il carnevale e Pasqua!) e abbiamo cambiato base. Alloggiare qui permette di visitare in mattinata il mercato che si sviluppa vicino al ponte-simbolo: fra le bancarelle di frutta e verdura, quelle più affascinanti sono quelle del pesce. Granseole, moeche, capesante: è un tripudio di colori in un vociare continuo. Non perdetevi la lapide con scritte le lunghezze dei pesci concesse nei secoli scorsi: è uno dei tanti tuffi nel passato che offre questa città.
6) Mangiare le moeche
Dopo averle viste al mercato, non potete non assaggiare questi granchi privi del guscio, disponibili soprattutto in primavera. La bontà si paga, ma se le provate nella Trattoria Antiche Carampane, non troppo distante dalla zona del mercato, ogni euro sarà ottimamente speso. Le moeche sono servite croccanti, insieme con altre verdurine. Provate anche i tagliolini con la granseola!
7) Casino Venier
Non è facilissimo trovare questo piccolo appartamento, che oggi ospita l’associazione Alliance Francaise (siamo dietro piazza San Marco). Suonate e salite verso il mezzanino: vi si aprirà un mondo uscito da un romanzo. Questo ambiente era un casino, un luogo mondano di gioco e divertimento, uno dei pochi rimasto così intatto (grazie a un ottimo restauro). Bellissimi gli stucchi, gli affreschi e i tanti piccoli artifici dell’epoca: come un buco nel pavimento per vedere il passaggio nella stradina sottostante o grate da cui usciva la musica suonata nella stanza vicina.
8) Libreria dell’acqua alta
Uscita di sicurezza. #libreriaacquaalta #venezia #venice
Una foto pubblicata da letizia (@letidzia) in data:
Appena si entra, dopo avere attraversato un piccolo cortile, c’è una gondola stipata di libri. E poi altre barche e vasche da bagno, tutte cariche di volumi. E’ un luogo più suggestivo che comodo per gli acquisti forse, ma sembra che alla Libreria dell’Acqua alta ci sia ogni libro possibile. Ci sono più sale piene oltre ogni modo, con tanto di punti pensati per fermarsi a leggere. Il mio preferito è quello davanti all’uscita di sicurezza: una porta aperta sul canale. E’ in Calle Lunga Santa Maria Formosa, 5176/B.
9) Un giro a Burano
Burano *latergram* #venezia #venice #burano
Una foto pubblicata da Patrick Colgan (@colgan78) in data:
Mi piacciono molto le isole della Laguna, in particolare la Giudecca, ma Burano è uno di quei luoghi che sembra galleggiare in una bolla. C’è un’atmosfera sospesa, un po’ malinconica, ma senza esagerare, grazie all’esplosione di colori che si offre ai visitatori. Tutte le case dei pescatori, infatti, sono dipinte con toni pastello: questa isola famosa per la lavorazione dei merletti è un piccolo arcobaleno. Considerate diverse ore per la visita: il tragitto in vaporetto è piuttosto lungo (la linea è la 12, che passa anche per Murano).
10) Pizzette a volontà
pizzetta con l’acciuga: felicità -#Venezia — Inviato da WhatsApp
Una foto pubblicata da letizia (@letidzia) in data:
La cucina veneziana è fantastica e va provata, anche se non sempre è a buon mercato (oltre al posto già citato al punto 6, un consiglio per mangiare bene e non spendere troppo: La Palanca alla Giudecca). Ecco, le pizzette sono un’ottima opzione per pranzare con pochi euro in una città fondamentalmente un po’ cara e sentirsi in pace col mondo. Adoro in particolare quelle con l’acciuga, ma in generale questa versione veneta con la base di pasta sfoglia mi fa impazzire. Le mie preferite sono quelle della pasticceria Nobile (Cannaregio, 1818), frequentatissima dai veneziani, altrimenti amo molto anche quelle dell’Aciugheta, nel Campo Santi Filippo e Giacomo (molto vicino a San Marco). Ma quanto sono buone, da accompagnare con un’ombra di vino bianco ovviamente!